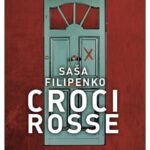La prima è il nome della scuola di italiano per stranieri in cui insegno ormai da diversi anni. È andata così. Per conoscere meglio alcuni degli alunni nigeriani arrivati a Nonantola nel 2011 a seguito dello scoppio della guerra in Libia, avevo accettato l’invito a cenare a casa loro. Abitavano in via Provinciale est nella bella e malconcia “casa bianca”, come ci divertivamo a chiamarla in onore del primo presidente nero degli Stati Uniti, conosciuta dai nonantolani come “casa dei tre comuni”. L’accordo era che loro avrebbero cucinato un piatto tradizionale nigeriano e io uno modenese. Per semplicità optai per il frisòun, come in casa mia chiamano il “friggione”, una padellata di pomodoro cotto a lungo e lentamente in un abbondante soffritto di cipolle. Solo che nello sforzo di memorizzare il nome dialettale della ricetta, Hakeem e i suoi coinquilini, tutti anglofoni, al posto di frisòun continuavano a capire free zone. E visto che un nome in quel periodo la scuola di italiano non ce l’aveva ancora, mi sembrò che quel fraintendimento fosse un bel viatico per una scuola che, tra le altre cose, ambiva a essere uno spazio franco e una zona libera. “Scuola Frisoun” è, da allora, il nome della scuola per stranieri che si trova in piazza Liberazione 20, tra la Cgil e la fonoteca.
La seconda cosa di cui sono debitore ai ragazzi dell’Emergenza Nord Africa e ad Hakeem in particolare è di avermi permesso di comprendere un po’ meglio i nodi e le contraddizioni che caratterizzavano il sistema dell’accoglienza a rifugiati e richiedenti asilo. Nodi che in questi dieci anni si sono tutt’altro che sciolti e che anzi si sono sclerotizzati in pratiche dell’accoglienza profondamente irrazionali, capaci di consumare e corrompere idee, spinte vitali e forze creative, tanto in chi è accolto (profughi, richiedenti asilo, minori non accompagnati) quanto in chi accoglie (educatori, operatori e assistenti sociali, funzionari pubblici e del privato sociale).


Tornando alla primavera del 2012, l’Unione del Sorbara propose all’associazione attraverso cui insegno di organizzare due mesi intensivi di scuola di italiano e di costruire alcuni percorsi di tirocinio formativo per Hakeem e gli altri ragazzi nigeriani (9 uomini e 2 donne) collocati a Nonantola nell’ambito della cosiddetta Emergenza Nord Africa. Se si esclude la luminosa vicenda di salvezza dei ragazzi di Villa Emma, prima del 2012 Nonantola non era stata interessata dall’arrivo di gruppi organizzati di profughi e richiedenti asilo. E a parte quello che raccontavano male e confusamente i media in occasione di qualche emergenza politica o di qualche tragedia umanitaria, io non sapevo praticamente nulla né della condizione giuridica dei richiedenti asilo, né delle politiche e delle pratiche attraverso cui essi entravano e tentavano di rimanere in Europa.
Per farmi un quadro più preciso, iniziai a cercare e a studiare il lavoro e le analisi dei giornalisti, delle associazioni e degli osservatori più attenti che in quegli anni portavano avanti istanze e progetti antirazzisti nell’ambito delle politiche migratorie. E fu relativamente semplice mettere a fuoco i limiti strutturali delle nostre politiche migratorie: assenza di una legge organica sull’asilo; una gestione diffusa sui territori senza che i territori avessero preparazione né strumenti operativi adeguati; convenzioni stipulate dalla Protezione civile prima e dalle Prefetture poi con soggetti che non si erano mai occupati di immigrazione e di “sociale” (alberghi, agriturismi, cooperative nate dal nulla per intercettare i fondi del sociale che si stavano spostando su quell’asse di spesa); il folle inserimento di tutti gli immigrati nel percorso della procedura d’asilo… Insomma, un enorme e complicatissimo groviglio di nodi di ordine giuridico, politico e burocratico.
Ma lentamente i conti iniziarono a non tornarmi. Raramente la matrice dei problemi che Hakeem e gli altri portavano a scuola erano direttamente riconducibili al razzismo istituzionale di cui erano e sono indubbiamente impregnate le politiche e le pratiche italiane dell’accoglienza. I conflitti, quando non l’aggressività vera e propria, e soprattutto l’anestesia delle spinte vitali dei miei studenti nigeriani, del loro istinto di sopravvivenza, l’annebbiamento della loro capacità di reagire e di “far da sé” che mi sembrano gli effetti peggiori che una relazione educativa possa produrre, mi apparivano spesso inevitabili e portati per così dire “a sistema” dalle relazioni d’aiuto di cui in quel momento erano oggetto. Non dipendenti principalmente dalla normativa vigente, né dalla mancanza di fondi negli interventi programmati, quanto dagli strumenti e dalla cultura professionale dei loro “assistenti”. Sarebbe a dire di noi educatori e operatori sociali.
Estremizzo, è evidente, ma molto spesso, di fronte alla confusione dei miei alunni nigeriani, alla loro rassegnazione, alla loro inedia, alle loro recriminazioni, giustificate o micragnose che fossero, mi ha sfiorato, e con una certa presa, un pensiero “cattivo”: che se non ci fosse stata tutta l’impalcatura assistenziale del programma di aiuto e degli attori che lo stavano attuando avrebbero avuto molte più chance di mettere radici.
I problemi che i miei studenti nigeriani portavano a scuola erano molto prosaicamente di quest’ordine: la sistemazione in territori isolati (lontano dagli occhi, lontano dal cuore…); una gestione infantilizzante e assistenzialistica delle loro giornate; la confusione primordiale, loro e dei loro “assistenti”, sui confini precisi del programma di protezione; l’altrettanto confusa sovrapposizione degli attori e delle istituzioni in ballo (per i miei studenti ma anche per molti operatori la commissione territoriale, i servizi sociali, la questura, la prefettura, il comune, la scuola facevano parte di un’unica indistinta nebulosa); la socializzazione al lavoro che assomigliava spesso a un riempitivo senza scopo, quando non a uno sfruttamento di manodopera a basso costo; infine quel misto di paternalismo, moralismo, controllo poliziesco, sistema di premi e punizioni, insieme seduttivi e autoritari, che mettevamo in piedi, spesso inconsapevolmente, noi operatori. Ecco se dovessi dire quello che di più inguaiava i miei studenti – anche in vista del momento in cui, finito il programma di accoglienza, se la sarebbero dovuta cavare da soli – può essere attinto da quest’ordine di problemi più che dalla mancanza di fondi o dalla legge, seppur assurda, che regolava e regola il diritto d’asilo in Italia. E in questo limbo, che come scoprii in seguito dura in media tre o quattro anni, in alcuni casi addirittura sei o sette, veniva compiuta un’enorme e profonda opera di infantilizzazione dalla quale solo chi riesce a transitarvi con un po’ di ironia, autonomia di pensiero e, se necessario alla vita, bordeggiando ai limiti della legalità, può uscirne, come Hakeem, preservando le proprie spinte vitali e la capacità di stare in piedi sulle proprie gambe.


La terza cosa che devo ad Hakeem e alle persone che in questi anni gli sono state vicino è la conferma dell’importanza del lavoro improntato allo “sviluppo di comunità”. Il lavoro di comunità non è un sentimento, una definizione generica e astratta improntata alla solidarietà e al “vogliamoci bene”, come normalmente viene venduto in questi anni. Non è il surrogato a basso costo di un welfare che si illude di intervenire a difesa degli esclusi e degli emarginati affidando a una generica comunità (di volontari, attivisti, uomini di buona volontà) quello che non è più in grado di fare a causa dei tagli economici di questi anni e dell’avvilimento della cultura professionale di operatori e assistenti sociali. Il lavoro di comunità ha una sua storia, una sua tradizione, dei suoi modelli di intervento, che in Italia coincidono con la nascita stessa del Servizio sociale territoriale (simbolicamente riconducibile al convegno di Tremezzo, vicino a Como, del 1946, che incardinò il nascente Servizio sociale al lavoro di comunità). Secondo una distinzione di ambito anglosassone che negli anni della Ricostruzione fece propria anche il nascente Servizio sociale italiano, il lavoro di comunità (community work) era il terzo e fondamentale momento che affiancava il lavoro sul caso (case work) e il lavoro di gruppo (group work). Un intervento complesso rivolto all’ambiente in cui vivono le persone fragili in modo tale che sia l’ambiente stesso a fungere da vettore di cambiamento. A certe condizioni lo sviluppo di comunità, e il lavoro di prossimità di cui è costituito, contribuiscono ad autopromuovere e a emancipare le persone laddove la burocratizzazione e la tecnicizzazione dell’assistenza le rende dipendenti e cronicizza i loro bisogni.


Infine Hakeem mi ha aiutato a mettere a fuoco, per contrasto, la tossicità e l’ambiguità insite nell’operazione di vittimizzazione degli oppressi che noi operatori, attivisti e militanti mettiamo spesso in atto, più o meno consapevolmente, nei confronti delle persone che intendiamo aiutare. Nel disordine rappresentato dall’Emergenza Nord Africa e dalle politiche migratorie che da quello snodo storico si sono andate via via consolidando, Hakeem è riuscito a transitare con mente desta e cuore vigile, con ironia, indipendenza e autonomia, senza bisogno di incarnare, come il sistema spesso costringe a fare, il ruolo della vittima. “Vittima” (di mafia, di tortura, di patriarcato, di persecuzione politica o razziale…) è diventata la parola a tutto tondo che sembra spiegare ogni conflitto e che in realtà, scansando la complessità, non spiega proprio un bel niente, complica la capacità di progettare la propria vita, etichetta e passivizza, offrendo al massimo un alone di salvatore a chi con “la vittima” solidarizza. Dentro quel ruolo, sebbene avesse tutti i diritti di farlo suo, Hakeem c’è sempre stato stretto. Quando gli si è aperta la possibilità di una vita normale – un lavoro, una casa e un documento valido – si è sfilato dalla realtà parallela dell’accoglienza e ha iniziato a vivere da uomo in mezzo ad altri uomini.