In una biblioteca di una scuola che insegna l’italiano a persone straniere non penseresti mai di trovare un’edizione dei lirici greci. Cos’hanno in comune ad esempio Saffo, Ibico, Stesicoro, Pindaro con le culture e le letterature dei 32 diversi paesi del mondo che abbiamo incrociato quest’anno alla Scuola Frisoun? Che senso ha parlare di Alceo o di Simonide con chi non ha a che fare con il “nostro” retroterra culturale? Non è semplice rispondere a questa domanda, forse basterebbe leggerseli per capire, ma proviamo a mettere giù qualche riflessione che speriamo possa interessare anche chi non ha esperienza diretta in quest’ambito e che magari faccia venir voglia a qualche insegnante di leggere i lirici greci ai propri studenti.
I greci e il nostro tempo: due globalizzazioni
Spesso si dice che conoscere i greci e il loro pensiero – nell’arte, nella letteratura, nella pura filosofia – significa riscoprire la propria “identità”, le “radici” dell’Italia e dell’Europa… In parte sì, seguendo la linea del tempo e le trasformazioni della storia, i greci sono stati i grandi maestri dei più pragmatici romani (semplificando, ovviamente) e dalla disgregazione di questo impero elenizzato gli stati europei hanno iniziato a formarsi, l’età moderna li ha rafforzati, sono nate le lingue romanze che hanno rappresentato la base delle lingue contemporanee eccetera eccetera fino ad arrivare ad oggi, come se il collegamento tra Omero e qualsiasi cittadino europeo fosse direttissimo. Non sto mettendo in dubbio che ciò non sia in parte vero, ma bisogna distinguere ciò che è classico da ciò che è classicismo: forse in pochi sanno che pure i Greci alle origini compirono sacrifici umani, che era normale a Sparta la pratica per noi disumana di abbandonare i bambini con malformazioni, che gli ateniesi stessi praticavano rituali segreti (i mysteria) e che anche i riti baccanali non erano un’invenzione di Euripide. Pertanto, avere a che fare con gli antichi greci, e, più in generale, con la civiltà classica, significa, non tanto cercare negli antichi la cultura in cui siamo immersi come europei, italiani, modenesi, nonantolani, ma innanzitutto calarsi in una realtà culturale diversa, nella quale bisogna estraniarsi dalle nostre prospettive occidentali moderne se si vuole avere uno sguardo effettivamente critico.
In un certo senso, allora, la distanza storica che separa l’uomo contemporaneo dall’uomo della Grecia antica è forse più o meno la stessa che separa due uomini che provengono da luoghi distanti della Terra, da status sociali contrapposti, da ecosistemi agli antipodi. Ecco perché dico che serve uno sguardo interculturale per poter capire e apprezzare meglio i greci, lo stesso sguardo che servirebbe per confrontarsi con le tribù indigene dell’Amazzonia o i boscimani del Sud Africa o i beduini del Neghev o gli abitanti del Nepal. Certo la globalizzazione ci ha resi tutti più vicini e ha mischiato molto le culture, senza escludere quanto c’era di primitivo – ormai anche nei posti più impensabili e poveri si trovano le antenne satellitari! –, ma pure i nostri greci furono operatori di una globalizzazione su vasta scala, almeno dopo le conquiste di Alessandro Magno nel IV sec. a.C.: civiltà che erano rimaste isolate e sconosciute per secoli (come i popoli dell’Indo) improvvisamente vennero travolte dall’ellenismo e si misero a erigere città dedicate al Macedone, a innalzare templi alle divinità del Pantheon greco, ad aprire nuove vie di commercio verso il Mediterraneo e soprattutto a parlare la lingua greca.
Questo accadde pure alla cultura romana, nonostante la strenua difesa del mos maiorum da parte di Catone: Graecia capta, ferum victorem coepit, scrive Orazio, “la Grecia conquistata, ha conquistato il feroce vincitore” – cioè la cultura di un popolo conquistato è riuscita a sopraffare e risultare vincitrice su quella del popolo conquistatore: dalla metà del II sec. a.C. in poi l’afflusso a Roma di opere d’arte greche, comprese quelle letterarie, operò una vera e propria ellenizzazione dell’originario costume latino.
Ma lo scambio fu reciproco: i popoli sottomessi dai greci (e poi dai romani) penetrarono nel nuovo tessuto sociale con le loro religioni, usanze, culture (si noti ad esempio il culto di Iside e Mitra che fanno breccia a Roma in età imperiale, o come Alessandro Magno si fosse proclamato figlio del dio del sole egizio Ra). Lo scambio non è mai stato unilaterale, ma sempre in un’osmosi continua. Penso allora che conoscere la civiltà greca, la sua cultura e i suoi sviluppi, significhi innanzitutto osservare la trasformazione e il pensiero di una civiltà che fece della sua cultura uno strumento di conquista, e che durante questa sua globalizzazione dovette lei stessa elaborare un approccio interculturale. Insomma, i greci hanno aperto la strada nella storia della convivenza e dello scambio tra culture.

Leggere i lirici greci: ritornare al primitivo
A questo punto torniamo ai lirici greci. Quando usiamo in italiano l’aggettivo o il sostantivo “lirica” facciamo riferimento in genere alla poesia in senso lato, ad un contesto elegante e raffinato, alla musica dei teatri del Barocco italiano, ma all’origine di questo termine c’è un’altra parola, lyra, la “lira”, uno strumento cordofono che veniva utilizzato per accompagnare certi tipi di poesia (non tutti!) in epoca classica, a partire dall’antica Grecia. Quindi già la definizione di “lirici greci” risulta impropria, ma rispecchia l’uso moderno che facciamo appunto di questa espressione; i filologi Alessandrini (dal III sec. a.C.) considerarono questi come i nomi più importanti tra gli autori di generi poetici raggruppati dentro il calderone dei “lirici”: Alceo di Mitilene (625 a.C.), Saffo di Mitilene (640 a.C.), Anacreonte di Ceo (570 a.C. – 485 a.C.) per la melica monodica, Alcmane di Sparta (seconda metà VII sec. a.C.), Stesicoro di Metauro o Imera (632 a.C.), Ibico di Reggio (540/536 a.C.), Simonide di Ceo (556 a.C.), Pindaro di Tebe (522 a.C.), Bacchilide di Siracusa (520/510 a.C.) per la melica corale, Archiloco di Paro (VII sec. a.C.), Semonide di Samo (metà VII sec. a.C.), Ipponatte di Efeso (prima metà VI sec. a.C.) per il giambo e infine per l’elegia Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone, Senofane, Teognide, Focilide. Come vediamo si occuparono di generi diversi di lirica, ognuno con peculiarità metriche, musicali, performative, l’insieme è vasto, ma anche molto vario all’interno. Proviamo a fare un po’ di ordine.
Osservando le loro date di nascita, i lirici greci comprendono una vasta schiera di poeti che operarono nella Grecia arcaica, quell’epoca che distinguiamo dalle successive età classica ed ellenistico-romana: sono dei poeti che in sostanza rappresentarono, un po’ dopo Omero ed Esiodo, gli albori della letteratura greca, ancora prima della grande tragedia, prima della fioritura della storiografia, dell’oratoria, prima degli studi filologici sulla letteratura stessa. Perciò mi piace dire che questi componimenti sono autentici (non filologicamente parlando!) con la loro provenienza storica, poiché furono recitati quando ancora si dovevano consumare quelle vicende che avrebbero sconquassato il corso delle età greche segnandole per sempre, dalle guerre persiane (inizio V secolo) alla guerra del Peloponneso (metà V secolo), e poi per l’assenza della retorica, che divamperà in Grecia con l’età classica, generando non poche discussioni anche tra i letterati stessi. In più, furono parte di quella letteratura primitiva che non si era ancora ellenizzata, meticciata con altre culture, che non aveva conosciuto quella “globalizzazione” di cui parlavo prima. Questi episodi successivi contribuiranno a creare l’alone di classicismo oscurando inevitabilmente invece il primitivo sentimento greco.
Infatti, parlare di civiltà greca, cultura greca, popolo greco, o addirittura etnia greca, significherebbe imbattersi in un terreno scivolosissimo. Intanto, quali greci? Quelli dell’età arcaica, con ancora retaggi micenei, ma di dialetto dorico, eolico, arcadico o ionico? Quelli dell’età classica, ma di quale polis, dato che queste città vivevano in perenne competizione? Pericle era ateniese, non greco! Quelli dell’ellenismo? Insomma, la definizione di grecità è imperfetta, così come sarebbe per me impossibile dare una definizione di italianità, inglesità, germanicità, ecc… Sì, Erodoto, che aveva ben in mente le guerre persiane, sapeva che la Grecia era tutto ciò che non erano i barbari persiani, ma se esuliamo dai confini territoriali, dagli statuti politici e dalle lingue ufficiali, si rischia sempre troppo di dare per scontato la complessità della nostra umanità. Il problema è che anche un’idea di cultura statica non esiste, specialmente per un popolo (ma erano davvero un popolo i greci?) che si disperse nello spazio e nel tempo: le tradizioni, i culti, il modo di vestire, le lingue sono un riflesso di uno spaccato temporale, non un monolite.
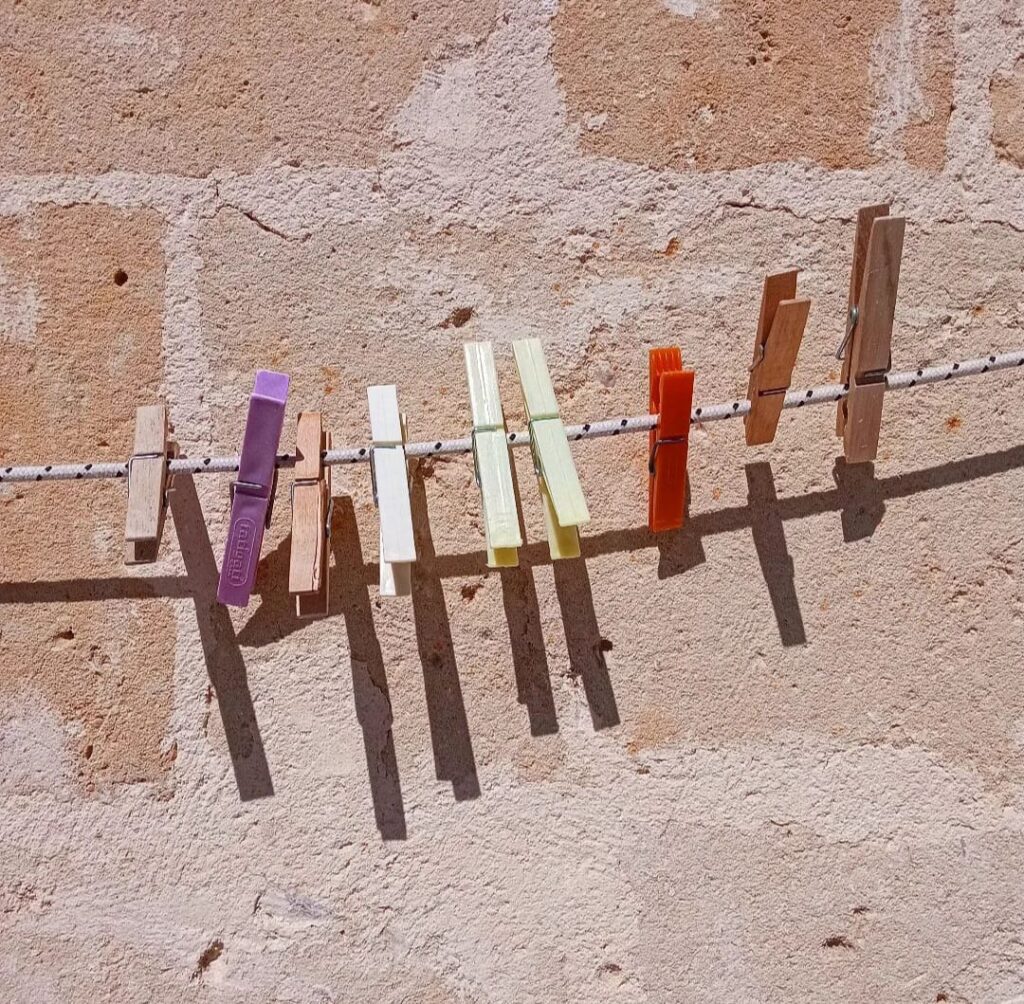
A questo proposito risultano interessanti gli studi storico-antropologici di Jan Assman in La memoria culturale. Il primordialismo ottocentesco prevedeva che l’ethnos fosse una comunità geneticamente determinata in più pratiche sociali e culturali. Questa idea ebbe effetti deleteri nella storia anche recente, facendo sorgere l’idea che quanto più una comunità fosse chiusa nel suo determinismo genetico, tanto più si sarebbe evoluta. Nell’antichità già il caso della prima e della seconda colonizzazione greca portò ad un primo incontro con indigeni di altri luoghi (i vari Polifemi, Ciconi, Lotofagi dell’Odissea!): i colonizzatori si unirono con le donne del posto formando una nuova comunità, geneticamente modificata, ma pur sempre greca, tant’è che dopo alcune generazioni i figli si riconoscevano greci a tutti gli effetti. Nel secolo scorso David Asceri affermò che i greci non fossero una “razza pura”, aggiungendo “chi ha il gusto delle razze pure è meglio che si rassegni a cercare queste cose altrove, non tra i greci”. Di qui nasce la necessità impellente per tutto il corso della storia delle comunità greche, delle poleis, dei vari ethne di forgiare miti di fondazione, memorie collettive che potessero cementificare la propria identità originaria, spesso passando dalla storiografia alla fantasia.
Ecco allora che i lirici greci ci aiutano a dare uno spaccato di questa varietà etnica della Grecia, intanto per il fatto che parliamo di poeti con provenienze diverse che usavano dialetti diversi – tra l’altro, giusto per complicarci il quadro, la loro lingua d’uso non era la lingua del genere poetico che producevano: ad esempio Pindaro, che abitò in Beozia per tutta la vita, fu autore di poesia corale in dorico, perché il genere stesso lo richiedeva. Ecco allora che questi componimenti ci restituiscono dialetti se vogliamo artificiali, costruiti a misura d’arte, ma che comunque ci dimostrano il profondo frazionamento e il conseguente miscuglio linguistico che si trovava nelle varie regioni della Grecia. Quindi nei frammenti leggiamo una profonda diversità linguistica iniziale, che si supererà lentamente con la vittoria della koiné dell’ellenismo: dal III-II sec. a.C. i dialetti greci sarebbero diventati oggetto di una riproduzione puramente erudito-antiquaria. Un altro motivo per cui i Lirici greci ci riportano all’idea di primitivo.
In terzo luogo, questi componimenti riflettono un mondo lontano, arcaico per l’appunto, dove ancora la poesia aveva un valore sociale e civile (non che adesso non lo abbia: le chiamiamo “canzoni”, ma sono sempre poietikà). La melica corale, per esempio, veniva cantata durante feste pubbliche, in onore di vincitori di agoni, di vittorie militari, in occasione di feste religiose: le fonti dicono che pure Sofocle, da ragazzo, avrebbe preso parte al peana che doveva celebrare la vittoria di Salamina contro i Persiani. Erano momenti molto forti, in cui doveva essere molto forte il senso di appartenenza a quella realtà cittadina. Altro contesto è quello della melica monodica, del giambo e dell’elegia, tre generi diversi, ma che venivano appunto tutti praticati a simposio, tra i membri della stessa eteria, vale a dire lo stesso partito, gli stessi compagni d’armi, di avventure e anche di visioni politiche, durante il simposio, un’usanza comune a tutte le famiglie aristocratiche del panorama greco, che consisteva in un banchetto dove, tra ricche prelibatezze e abbondanti bevute, si discuteva di filosofia, di politica, si scherzava, si recitavano giambi ed elegie e si cantava meliche con l’accompagnamento della lira. E poi c’era il giambo, un genere recitativo, dove l’accompagnamento dell’aulos consentiva di scandire i toni scazonti e scanzonati, dove l’invettiva, l’insulto aperto, il tema scabroso dovevano intrattenere il pubblico aristocratico. Infine, l’elegia, dai toni più malinconici o più propriamente appassionati, che si distingueva per il suo metro (distico elegiaco) particolarmente sinuoso. Leggere quindi queste parole in metrica significa provare ad immaginare di essere in un mondo altro, che continua a parlarci anche se in maniera diversa, anche se non proveremo le stesse emozioni: ma se hanno parlato per secoli, non inizieranno proprio ora a tacere! Si tratta di un vero e proprio viaggio, nello spazio e nel tempo.

Sullo scaffale di una scuola di italiano
Ma torniamo da dove siamo partiti: oltre che affascinanti, per chi ha a che fare con culture diverse, i Lirici greci possono essere utili per chi è alle prime armi con l’italiano? Nell’ottica di insegnamento dell’italiano come “lingua seconda”, questi componimenti si prestano bene perché innanzitutto sono brevi, con una sintassi poco articolata, e con una buona ed essenziale traduzione possono arrivare anche all’orecchio meno esperto. C’è da sottolineare un fatto: la tradizione ci ha riportato queste poesie in forma frammentaria, o su papiri spesso di complicata lettura o come citazione di autori successivi. Il che rende certo tutto più intrigante, ma anche più difficile per la comprensione: lacune di interi versi inficiano lo sviluppo coerente della narrazione. I filologi che si occupano di questo tipo di componimenti compiono ricerche su ricerche per comprendere in modo plausibile e scientifico cosa ci fosse scritto, come continuasse il componimento, uno sforzo che il più delle volte non porta a risultati, ma anzi, apre nuovi interrogativi. Del resto, la poesia del frammento di Ungaretti nel ‘900 si basa proprio su questo principio: riuscire a concentrare in poche superstiti parole, concetti, immagini, sentimenti profondi che riescono a dire più di quello che di per sé stessi rappresentano. Perché quindi non fare questo sforzo inverso, e cercare di apprezzare la nudità delle parole superstiti? Ma c’è di più: la poesia greca, scritta da uomini per altri uomini, è una poesia che parla, che vuole dialogare con chi la legge, il contrario dell’ermetismo. Per questo i sentimenti che afferma sono in maggioranza sentimenti universali, come il frammento di Mimnermo (fr.2 W2), in cui si mette a nudo la fragilità dell’esistenza umana, in balia della vecchiaia e della sofferenza, o il celebre carme di Saffo (fr. 31 V) in cui la poetessa descrive la sensazione dell’innamoramento con effetti anche somatici, o il fr.13 W2 di Archiloco, dove si piange per la morte di cittadini in seguito ad un naufragio.
L’amore, il piacere, la povertà, la morte, la passione politica, sono solo alcuni dei grandi macro-temi che i poeti greci affrontano nei loro componimenti, temi che in tutte le culture, di tutte le civiltà, di tutti i popoli, di tutte le nazioni rappresentano un minimo comune denominatore. E penso che certamente sia sempre importante fare l’esercizio di trovare ciò che ci accomuna in nome di una comune umanità, ma anche quello di trovare le differenze per la ricchezza che ognuno rappresenta nel mondo. Per questo credo che i Lirici greci possano essere anche un utile strumento di discussione, tra il testo, il lettore e la contemporaneità, dal momento che certi temi furono scelti dai poeti in maniera apertamente provocatoria, e ancora ci possono provocare. Forse fu proprio questo, infatti, l’intento che spinse Archiloco a scrivere il fr. 5 W2, in cui si legge:
Ἄσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνῳ,
ἔντος ἀμώμητον,‖κάλλιπον οὐκ ἐθέλων
αὐτὸν δ’ἐξεσάωσα. τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐκείνη;
ἐρρέτω·ἐξαῦτις‖κτήσομαι οὐ κακίω.
“Uno dei Sai si gloria dello scudo, che presso un cespuglio, strumento perfetto, dovetti lasciare, pur senza volerlo; la vita, dall’altra parte, l’ho salvata: che cosa mi importa di quello scudo? Che vada in malora: di nuovo me ne procurerò uno, migliore” (trad. Camillo Neri).
Lo scudo che nei poemi omerici aveva rappresentato il valore militare, in diretto rapporto con lo thymós del soldato che lo portava (si pensi alla descrizione ecfrastica dello scudo di Achille nel libro XVIII, Iliade, vv. 483-598) è ora stato abbandonato. Si ribaltano i valori civici del cittadino guerriero, pronto a dare la sua vita in cambio dell’onore: la morte in armi per mano nemica (il popolo dei Sai), lascia il posto alla fuga dal campo di battaglia. Questa fuga è scomposta, per niente eroica: pure lo scudo viene perduto.
Cosa ci dice tutto ciò? Certamente non che Archiloco fosse un ribelle o un anarchico, ma che sicuramente quei valori militareschi che fondavano la società della polis potevano essere messi in discussione, o quanto meno diventare oggetto della risata ironica in uno degli aristocratici simposi. Allo stesso modo, lo sguardo di straniamento che utilizza Archiloco su questo tema (e che poi userà Erodoto!) apre una serie di discussioni interculturali, a partire dall’interrogativo: ha fatto bene Archiloco ad abbandonare lo scudo? E poi, c’è un “antieroe” anche in altre culture, in altri contesti?
Ha senso in conclusione avere una edizione dei Lirici Greci anche alla Scuola Frisoun? Sì, ha senso, aiuterà maestri e studenti a condividere opinioni, a scrutare nel profondo oltre la carta del libro, a immaginare a occhi chiusi un mondo ormai lontano, ma che ci sembra così vicino, a confrontare situazioni impossibili, ma parallele, insomma possono davvero aiutarci a fare interculturalità.
Le fotografie che accompagnano questo articolo, dal titolo “Frammenti”, sono della nostra redattrice Agnieszka Pawula, che scrive questo di sé:
“Ho sempre pensato che le fotografie siano come le barzelletta, se devi spiegarle vuol dire che non sono venute bene” (Ansel Adams)
Agnieszka Pawula, polacca, da 26 anni in Italia. Con una grande passione per la fotografia e i viaggi perché proprio questi sono la migliore scuola della vita. Mi piace osservare il mondo e la gente.





